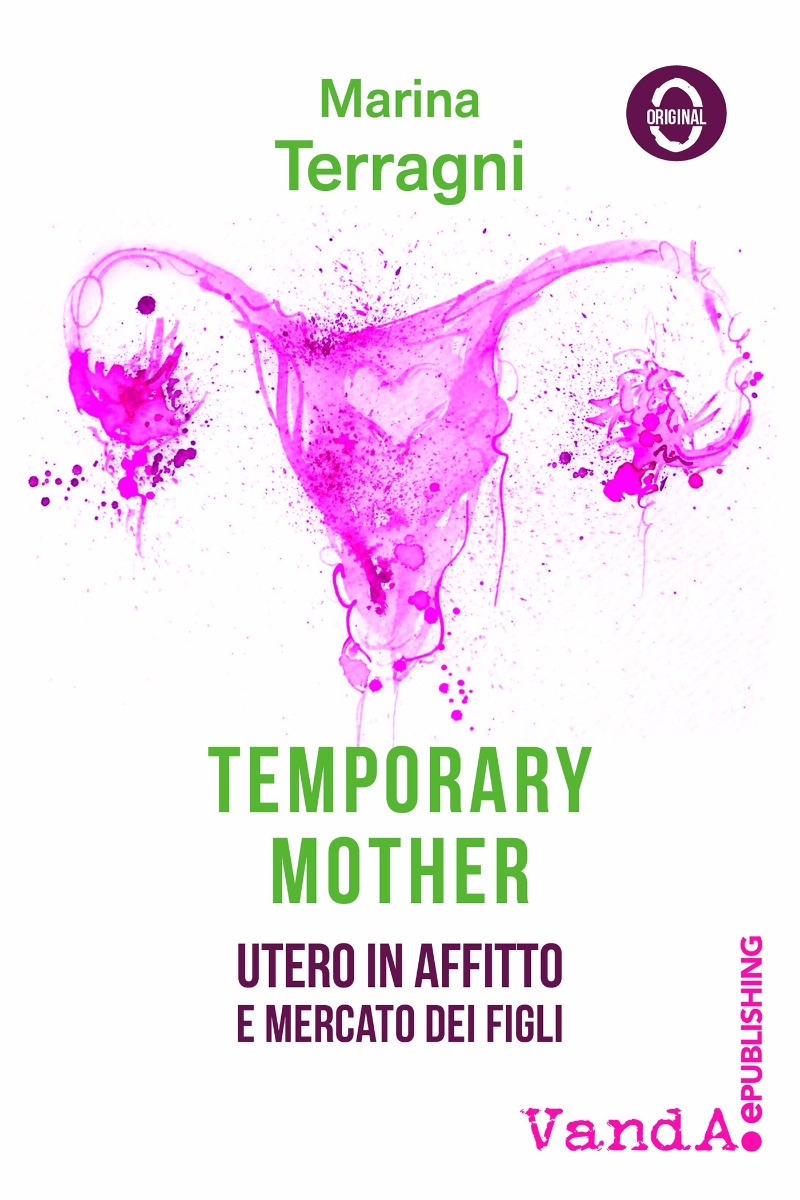
di Susanna Tamaro (Corriere della Sera, 5 luglio 2016)
– Il fondamento della vita è la genealogia. La storia di chi ci precede fa di noi persone. L’intervento di Susanna Tamaro.
Appena ho terminato la lettura del coraggioso e attualissimo pamphlet di Marina Terragni, Temporary mother (VandA ePublishing), mi è sorta spontanea una riflessione: come mai è stato accolto da un siderale silenzio? E subito è seguita una domanda: quanti sono i fondamentalismi del nostro tempo? Ce ne è uno macroscopico — quello religioso — che per le sue tragiche conseguenze è purtroppo noto a tutti. Ma non se ne annidano forse altri intorno a noi, più miti, più benefici, apparentemente più innocui? In fondo la scomparsa delle ideologie del ‘900 e l’innegabile eclissi del cristianesimo hanno lasciato un grande vuoto di etica e di orizzonti, e il vuoto non è facile da reggere. O si accetta di attraversarlo — consapevoli che l’incertezza fa parte del destino dell’uomo — oppure ci si attacca a qualcosa, a un particolare, e si trasforma quel particolare nel metro della totalità; da quel momento in poi, tutto quello che non si conforma alla totalità che ci rappresenta va combattuto. E in che modo? Con l’invettiva, la ridicolizzazione, la derisione: tutte armi che il mondo della rete offre con democratica generosità. Per linciare una persona basta un click, in meno di un secondo si guadagna la certezza di essere dalla parte giusta del mondo, senza mai essere sfiorati dal dubbio che la parte in cui ci riconosciamo sia soltanto un microscopico spicchio della realtà totale. Questi fondamentalismi domestici — che potremmo chiamare identitari, perché ci si identifica completamente con un’identità parziale — sono particolarmente vivi e attivi nel campo della bioetica, campo a cui la Gpa appartiene di diritto.
Gpa, gestazione per altri. Non occorre essere dei filosofi del linguaggio per capire che la prima e più grande manipolazione del pensiero avviene attraverso le parole. Parlare di «pulizia etnica», ad esempio, è molto diverso che dire «sterminio di massa» perché se c’è del pulito, il nostro inconscio automaticamente pensa che qualcosa in fondo di buono c’è. E così dire «gestazione per altri» e tutt’altra cosa che dire «utero in affitto». Il concetto di affitto porta con sé l’idea, infatti, dell’oggetto e del commercio — grazie al denaro, posso affittare una macchina, un appartamento — mentre la definizione «per altri» ci indirizza verso una positività buonista che rende questa condizione, non solo accettabile, ma anche desiderabile. Ne consegue che tutti coloro che si oppongono a questo progetto sono persone retrive, egoiste, prigioniere di un oscurantismo che non ha più senso di esistere, e — soprattutto — nemiche della Felicità e dell’Amore, i due grandi Totem all’ombra dei quali vive prostrato il nostro tempo. Come puoi pensare, infatti, di negare a qualcuno il diritto di essere felice, il diritto di amare?
Non è forse con la stessa suadente strategia che i predatori di ovuli — quest’abominevole categoria di «benefattori» — si aggira tra le giovani ragazze? «Non vuoi rendere felice una coppia a cui il destino ha negato questo diritto? C’è gente che dona un rene e tu sei così egoista da non voler donare un misero ovetto? Ci guadagni anche due soldini di rimborso, che fanno sempre comodo…». Per delle bambine cresciute con gli ovetti Kinder, questo discorso sembra innocuo, convincente. In fondo che c’è di male? Tranne poi dire, come ho letto in un’intervista fatta a una ragazza donatrice: «Oddio, non è che poi da qualche parte ci saranno dei bambini che mi assomigliano?».
Sempre per l’esercizio di chiamare le cose con il loro nome, gli ovetti — diciamolo allora, per chi zoppica in biologia — sono i nostri figli. Figli che prima iberniamo e poi lanciamo nel mondo come fossimo piante che si affidano alla fecondazione anemofila. Spargiamo semi senza sapere dove andranno a finire. Noi, le madri, non verremo mai a conoscere il loro destino. Può esistere qualcosa di più atroce di questo? La maternità — la condizione fondante del vivente — ridotta a livello delle piante, senza identità individuale. La genealogia ridotta a quella uniformante della specie.
Ma forse è proprio qui, contemplando il punto più basso dell’abisso, che il bio business getta la maschera e fa vedere il suo vero volto, che non è quello di un salvatore bensì quello di un famelico generatore del nulla. Attaccare la maternità, distruggere le sue viscere misericordiose vuol dire attaccare e distruggere i fondamenti del mondo. Per capire questo non occorre essersi rimpinzati di opuscoli Pro Life, basta aver visto almeno una volta una gatta a cui siano stati sottratti i gattini, la trepida cova di una rondine, le povere donne che scendono dai barconi stringendo al petto i loro figli sopravvissuti all’orrore. Basta ricordare l’ultima telefonata di quel povero ragazzo morto nella strage di Orlando: «Mamma, sto per morire, ti voglio bene». O basta anche, semplicemente, ricordare la morte della propria madre. Con la Gpa tutto questo non potrà avvenire, perché la super donna, super generosa — la complementare della donatrice — la donna che tutte noi dovremmo ammirare, cede immediatamente ad altri il frutto del suo ventre.
La verità scientifica — elevata nel nostro tempo a unica verità — a questo punto diventa afasica, muta, inessenziale. Tutti i meravigliosi e straordinari studi sugli intensissimi rapporti che intercorrono in quei nove mesi tra la madre e il suo bambino diventano carta straccia. Nel tempo della fattibilità, il piccolo è ridotto a cosa, viene assemblato in un luogo indifferente ma il suo esistere ridiviene reale soltanto nel momento in cui viene onorato il contratto e consegnato nelle mani dei felicissimi committenti. D’altronde, come dar loro torto? Ogni bambino è un miracolo davanti a cui rimaniamo tutti a bocca aperta! Però, questo miracolo ha un piccolo difetto. È un essere umano e, in quanto tale, probabilmente prima o poi comincerà a farsi domande.
Già perché, assieme agli studi scientifici, sono finiti nel cassonetto decine di capolavori della letteratura con protagonisti giovani orfani o figli illegittimi alla ricerca perenne del volto della madre, un paio di secoli di studi psicologici, l’intera psicanalisi. Il bambino Gpa è un bambino tabula rasa, nasce senza alcun passato e vive — e sappiamo già che sarà felice perché è stato desideratissimo — in un mondo che gli promette un amore incondizionato. Ma quando, un giorno, si guarderà allo specchio e capirà che non potrà mai risalire all’origine di una parte del suo volto, l’amore basterà? E basterà quando si renderà conto che sua madre, per un compenso, ha venduto l’ovulo che l’ha generato, cioè la sua vita?
Se penso alla mia famiglia, la parola «amore» è forse la trentesima che mi viene in mente e la maggior parte delle parole che la precedono non hanno certo una connotazione di positività, eppure io sono quella che sono perché ho avuto quei genitori. Genitori a loro volta generati da altri genitori. Il fondamento della vita umana dunque è la genealogia, non l’amore. Si può nascere anche da uno stupro, si può crescere in un lager. Ciò che fa di un essere umano una persona è prima di ogni altra cosa la storia di chi ci ha preceduto. In nome di che cosa mi chiedo allora, una persona, per esercitare il suo diritto alla felicità, può coscientemente privare un altro essere della sua genealogia? In nome dell’amore? Ma un amore che priva programmaticamente, per principio, qualcun altro di un ben più fondante diritto, che amore è?
E qui va smascherato il secondo passo del bio business. Dato che non esiste la maternità, non esiste neppure il destino. Nessuna unicità appartiene all’uomo. Non è importante sognare, pensare, combattere, danzare. Il corpo a corpo karmico non ci riguarda più. L’esteso campo del mistero — quel campo che ci rende davvero umani — è stato conquistato dalla tecnica ed è lei a preparare per noi delle vite indolori, immerse dall’inizio alla fine nella rilassata piacevolezza del suo Amore.
Le energie messe in moto per propagandare questa nuova visione dell’umano sono potenti, sempre pronte a esaltare con tutti i mezzi un singolo caso, capace di mettere in ombra, con la sua forza emotiva, i principi etici che da migliaia di anni governano la vita degli uomini. Non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te stesso è il cardine principale su cui si fonda ogni civiltà degna di questo nome. Faccio outing: non vorrei mai essere nata da una Gpa. Nonostante mia madre non sia stata un esempio di amore materno, dalla sua morte in poi c’è un grande vuoto nella mia vita.
Per difendersi da questa aberrante visione del mondo, si dovrebbe prima di tutto cominciare a smantellare il grande ombrello dell’Amore Incondizionato, riportando questo importantissimo sentimento a due categorie fondamentali — l’amore generativo e l’amore oblativo — per ricordarsi che non poter generare non vuol dire non potere amare, anzi l’amore oblativo è spesso più grande e più libero di quello generativo.
E allora perché non lavorare strenuamente nel campo degli affidi e delle adozioni? I tre, quattro anni abituali di attesa, ad esempio, ridotti a nove mesi, il tempo di una gravidanza? Perché non pensare a Incentivi economici, apertura ai single e alle coppie omosessuali quando sia manifesta una stabilità affettiva? Togliere la maggior parte dei bambini dalle situazioni di anaffettività dell’abbandono dovrebbe essere il primo pensiero di una società umanamente degna. Perché, come dice il Talmud, «chi salva una vita salva il mondo intero», e questa salvezza — che nasce dall’amore oblativo — è l’unico vero e umile antidoto che possiamo opporre alla Gpa e allo strapotere del bio business sulla vita.







