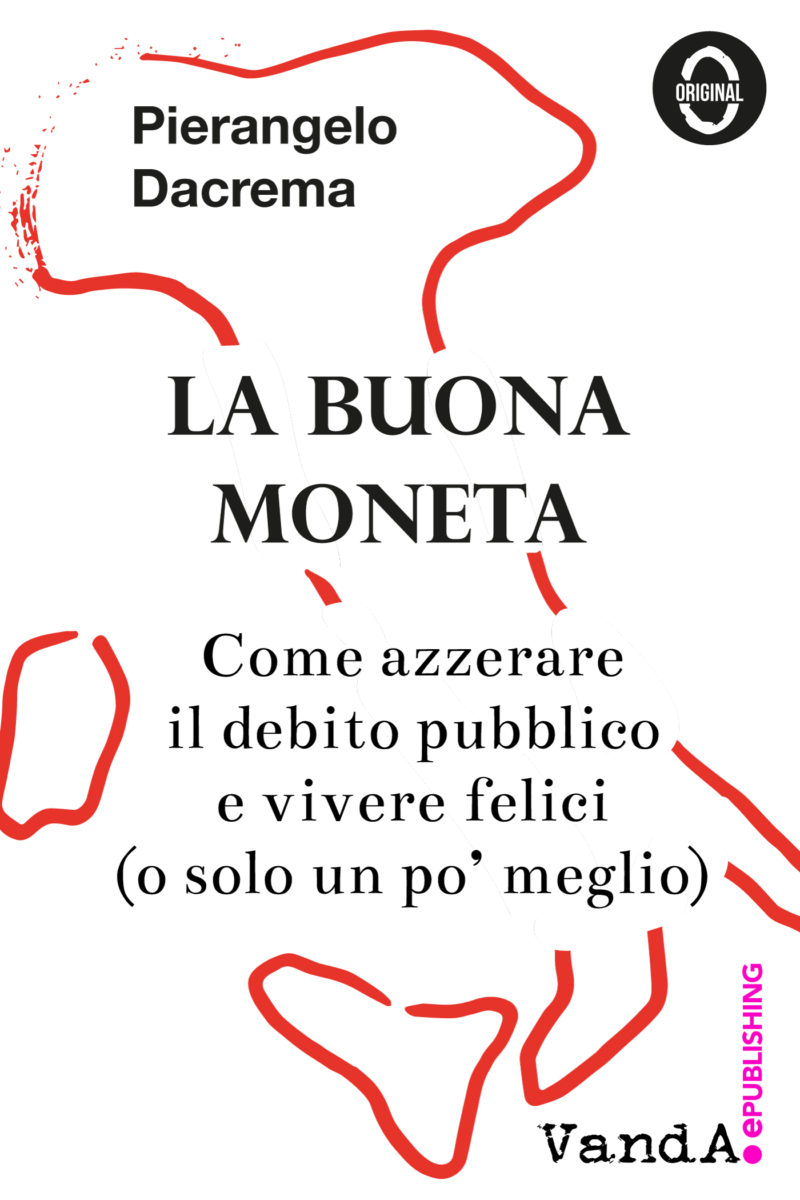di Michela Pagarini (Lettera Donna, 24 maggio 2018)
– È stata una delle prime in assoluto in Italia, quando un giorno del ’64 convocò una riunione di donne. Dall’utero in affitto a #MeToo, intervista a una pioniera.
«In molti miti e racconti il patriarcato è nato dopo anni di prevalenza del femminile. Gli uomini a un certo punto hanno cominciato ad innervosirsi e alla fine hanno ribaltato gli equilibri di potere».
Cinquantaquattro anni di femminismo attivo alle spalle, tre libri di cui due autoprodotti, un gruppo di autocoscienza che ha fondato e che da quattro anni si incontra alla Casa delle Donne di Milano e una presenza quotidiana su Facebook, dal quale racconta in pillole la sua visione del mondo. Daniela Pellegrini – fondatrice del Demau, uno dei primi gruppi femministi italiani e più tardi – insieme a Nadia Riva – del circolo delle donne Cicip & Ciciap a Milano – una vita intera dedicata e immersa nella passione femminista, non ci gira intorno e sempre di più sogna «un risveglio collettivo delle donne, che le renda libere prima di tutto dalla fascinazione del maschile e dalle sue scale di valori». Come si può riassumere la differenza fra i generi? «Semplice: da sempre le donne rischiano la morte per dare la vita. Gli uomini, invece, rischiano la vita per dare la morte». Con Daniela, in libreria con La materia sapiente del relativo plurale, abbiamo parlato delle lotte del ’68, ma anche di utero in affitto e ovviamente #MeToo.
DOMANDA: Lei è una delle femministe più longeve d’Italia, come è iniziato il suo percorso?
RISPOSTA: Da giovanissima mi angosciava molto il mio destino. La specie umana, con i suoi meccanismi violenti e le logiche di sopraffazione su tutto e tutti, ma essenzialmente sulle donne, non mi sembrava il posto adatto a me. «Cosa ci faccio qui, cosa c’entro con questa umanità?», mi chiedevo con inquietudine. La mia visione del futuro era così opprimente che, mentre crescevo, ho pensato spesso al suicidio perchè non vedevo alcuna collocazione felice né come essere umano né, men che meno, come donna.
D: E poi cos’è successo?
R: Dopo tanto riflettere, nel 1964 ho avuto l’intuizione di convocare una riunione di donne, le uniche con cui sentivo di avere un terreno comune da cui partire a riflettere. È nato così il primo gruppo femminista in Italia: Il suo nome era DACAPO (Donne a Capo). Quel gruppo è stata la mia salvezza.
D: Perché?
R: Col senno di poi, credo che non sarebbe potuto andare diversamente: per come mi sentivo e per come vedevo il mondo, l’unica cosa possibile per me era cambiarlo, o almeno provarci. E così ho fatto.
D: E vi ha dedicato praticamente tutta la vita.
R: Molte donne l’hanno fatto oltre a me, anche se io certamente sono una delle più vecchie. Ma come avrei potuto farne a meno? È il senso stesso della mia esistenza ad essere messo a tema. È l’unica passione che mi ha preso davvero nella vita, ed è anche rassicurante, perchè ho sempre pensato che sarà il soggetto donna a dare un altro significato all’esistenza della specie. Su questa convinzione ho basato tutte le mie passioni e, ahimè, da lì sono derivati anche tutti i miei dolori.
D: Per esempio?
R: L’inizio dell’inquinamento patriarcale. Oggi si dice che tutto è partito dal ‘68? Molte donne che avevano appena cominciato ad interrogarsi e riflettere, soprattutto attraverso l’autocoscienza – che si faceva in condizioni di intimità nelle nostre case, sono fuggite davanti all’invasione delle donne attiviste, ai loro toni, alle piazze. Dal ‘68 in poi fu chiara la differenza enorme che c’era tra la politica delle donne e quella tradizionale della delega. Le «compagne» contavano sulla complicità dei compagni di altro percorso, evidentemente supponendo che un movimento avrebbe appoggiato l’altro.
D: E invece non ha funzionato…
R: No, perché la commistione distraeva le donne e sottraeva forze ai nostri obiettivi più specifici e soprattutto dalle nostre pratiche, che si stavano ancora strutturando. E infatti alla lunga la presenza delle sessantottine ha sbilanciato completamente il movimento delle donne, a cui prima di quel momento partecipavano anche quelle non politicizzate, le casalinghe e quelle senza riferimenti precisi. Tutte sparite, dopo quella fase. Dopo quel passaggio il movimento ha perfino cambiato nome: ha preso a chiamarsi femminismo quando dalle case siamo scese nelle piazze.
D: Ve ne siete accorte solo a posteriori?
R: No anzi, lo vedevamo chiaramente, tant’è che all’inizio (io ma anche altre due pioniere come Carla Lonzi e Serena Castaldi) non accettavamo nemmeno che entrassero nei nostri gruppi donne che militavano contemporaneamente in ambiti misti. Se volevano stare con noi, allora dovevano abbandonare l’attività con gli uomini. Quella sì era radicalità di scelta politica e di movimento, oggi non credo esista più niente di simile, e mi piacerebbe ricostruirla.
D: Cosa facevate, su cosa vi interrogavate?
R: La nostra modalità principale di confronto era l’autocoscienza, pratica che tutt’oggi ritengo ancora necessaria per mettere in luce i meccanismi del patriarcato e ciò che hanno prodotto. Ci siamo tutti convinti che il mondo si divida in opposti che o si attraggono o si uccidono, una visione che contempla solo la possibilità di essere alleati o nemici e che prevede sempre e solo un vincitore e un vinto. È un’idea del mondo che purtroppo è diventata anche la base del movimento delle donne, ma per quanto mi riguarda è soltanto la base del grande bluff del patriarcato.
D: Che sarebbe?
R: Tutto ciò che è stato elaborato ed è substrato delle nostre vite si basa sul fatto che metà dell’umanità ha preso il potere, basando il suo predominio sulla denigrazione, l’espulsione e lo sfruttamento dell’altra metà e prendendo potere sulla materia e sui corpi, attuandone poi la separazione forzata dal pensiero. Anche termini banali come maschile e femminile per esempio, concorrono a questo meccanismo, perché si portano dentro tanti e tali stereotipi imposti che inevitabilmente si finisce in un braccio di ferro.
D: Come si cambia la narrazione di un’intera realtà?
R: Bisogna sfatare il mito del leader e l’idea che sia forte chi ce l’ha più duro. Oggi, per esempio, moltissime donne vogliono risultare vincenti, un concetto tipicamente legato al potere e alla viriltà dal quale spesso originano anche scelte disastrate e disastrose per loro stesse. Per inseguire quelle scale di valori è necessario infatti deformare di parecchio il concetto di autodeterminazione, fino ad arrivare alla svalorizzazione di sé e ad accettare che il proprio corpo venga sfruttato e la propria esistenza posseduta o governata da altri.
D: Si riferisce a questioni come la gestazione per altri? Che ne pensa?
R: Beh, anche quella. Cosa posso dirti? Capisco ma non intendo (ride), mi è difficile entrare in una critica vera e propria di questa questione, almeno per come viene posta normalmente, perché non è niente di nuovo, anzi. La retorica del dono d’amore (il figlio) al maschio, è sempre stato il violino suonato dal patriarcato alle donne, esiste da secoli. Adesso, semplicemente, il dono non è più al maschio prescelto ma a chiunque si prenda quel potere o trovi il modo di farselo dare. Ora è sempre più accettata la loro monetizzazione: il denaro sostituisce e cancella la sacralità dei corpi, la relazione e il senso del rispetto.
D: Insomma una donazione un po’ coatta.
R: È sempre stato così, perché diciamo la verità: non tutte le donne desiderano partorire e non credo che tutti gli uomini vogliano inseminare qualcuno, anche se si dà per scontato il contrario. La procreazione tradizionale prevede due parzialità che si devono mettere insieme per poter fare un figlio, tentare altre vie implica la scelta di un rapporto di potere anziché la scelta di una relazione autentica. Ed è qui che secondo me c’è il nodo di tutto, la dipendenza che ogni relazione mette in atto e che nella famosa scala di valori patriarcale non è contemplata. Va rivalutata e accolta invece, e bisogna farla diventare un valore anziché una sudditanza.
D: E come si fa?
R: Beh, basta accettare che nessuno può vivere senza dipendere da tutto il resto, la materia vivente è legata indissolubilmente a tutte le altre materie, dalle piante alle api, dalle quali dipende la nostra sopravvivenza. Ecco perciò l’importanza anche del linguaggio, altro punto caro al femminismo: quanto ci piace pensare di non dipendere da nessuno? Smettiamola di raccontarci storie: non è possibile.
D: Men che meno nell’autonomia fra uomini e donne?
R: Ho letto da qualche parte che nei ventri tutti i feti all’inizio partono come XX, e questo mi fa ben sperare che questo femminile alberghi e rimanga anche nei DNA che poi si trasformano in XY. Siamo tutte e tutti pieni di cromosomi misti, nessuno è puro, né nel sesso né nel pensiero. Data quest’evidenza, vorrei allora che emergesse ciò che c’è di buono in questa base comune e che ci aiutasse ad accettare tutte le nostre parzialità. Le differenze ci sono e ci saranno sempre, non serve definirle, combatterle o imporle, che senso ha basarvi un intero sistema esistenziale?
D: Come facciamo ad analizzarle, essendovi immerse?
R: Il separatismo è un altro strumento molto utile in questo senso, perché permette di individuare e assumersi la responsabilità del doppio che ognuno di noi ha dentro di sé. Così come mi piace pensare che in ogni uomo ci sia un po’ di quella doppia X femminile originaria, altrettanto so che in ogni donna alberga la cultura patriarcale in cui siamo cresciute.
D: E quando i contesti separati si dividono, come nel caso dei diversi femminismi?
R: Il concetto di femminismi è la negazione stessa del femminismo, che ha sempre avuto una base unica e comune da scardinare, il patriarcato e la cultura che ne deriva, basata su contrapposizioni e abusi. Nel movimento delle donne peraltro era già prevista ogni differenza individuale, libertà di pensiero, opinione e diversità, perché ognuna aveva come mandato, ancora prima della battaglia sociale, l’attenzione alla propria autenticità. Perciò il termine femminismi per me non ha senso, riporta tutto alle contrapposizioni e alle differenze.
D: I famosi conflitti fra donne… che si fa?
R: La cosa più semplice è ricominciare a fare autocoscienza, che si differenzia da tutti gli altri modi di parlare e confrontarsi grazie alle sue basi di ascolto e non giudizio. Ti insegna a riportare tutto a te e alle tue contraddizioni, abbatte le distanze con le altre donne e ti mette dentro di te anche quando discuti di qualcosa di apparentemente esterno. Senza queste modalità si arriva a poco, ma può essere molto difficile riuscirci, perché significa mettersi in discussione davvero nel profondo, soprattutto sui propri traguardi. Per me non si è mai arrivate a un punto di arrivo.
D: Parliamo di #MeToo e delle denunce che si levano da molti settori: qualcosa sta cambiando?
R: Sta mutando la consapevolezza dei danni che fa questa cultura, ma mi sembra che ancora non si mettano in risalto le basi su cui poggia questo potere di fare malversazioni sulle donne. Sono avvisaglie di un inizio, dall’Ottocento a ora ci sono stati miglioramenti, almeno qui da noi, ma per ora mi sembrano rimanere all’interno di un paradigma che non viene nominato. Se non cambia il sistema, se non cambiano le donne, non cambieranno nemmeno gli uomini, al massimo ci staranno un po’ più attenti.
D: Insomma dobbiamo cambiare ancora noi…
R: Beh sì. Qualche tempo fa ho assistito all’entusiasmo di un gruppo di donne per una rappresentazione dell’Otello, erano davvero ammirate, bei costumi, bella regia. Però io dico: è una rappresentazione storica e «artistica» del femminicidio, nella quale si dice che è giusto che Otello sia geloso e che lui abbia il potere di uccidere Desdemona. Da secoli le donne assistono a questa rappresentazione, applaudendola e finanziandola perché opera di un genio, senza riflettere sui suoi contenuti e messaggi. Questa è la fascinazione del maschile che dobbiamo combattere o certe cose non cambieranno mai.
D: La strada è ancora lunga, insomma.
R: Sono ottimista. A parte certe donne acute che sono sempre esistite, il femminismo è assai giovane e non si può pensare che in pochi anni possa cancellare e superare tutti i secoli di patriarcato che abbiamo sulle spalle e tutti questi crimini che vengono perpetrati contro di noi (e contro altri uomini) da secoli.
D: La politica può aiutare?
R: Una volte le femministe non dialogavano volentieri con la politica, nell’idea che un sistema a misura d’uomo non potesse essere utile per scardinare quel sistema stesso. Oggi invece c’è la corsa, tutte vogliono esserci, e allora penso che chi ci crede dovrebbe unirsi alle altre e fare un partito di donne, o come pensano di fare un cambiamento insieme a chi non vuole cambiare? Non credo sia la strada adatta agli obiettivi del femminismo, ma posso capire chi vi punta per cambiare leggi che vietano libertà alle donne o al contrario costringono loro a cose che non desiderano.
D: Quindi non condivide la politica come mezzo ma ne comprende il desiderio?
R: Credo sia inevitabile, a un certo punto, desiderare di entrare all’interno di quel potere di cui cerchiamo di smontare dalle basi. Una volta provata l’ebbrezza di aver partecipato o vinto una battaglia, è difficile rinunciarvi. Tale gioia ti incastra nella contraddizione tra il volerci essere ancora e il desiderio di provare altre vie per cambiare la situazione. Questa è la cosa che mi fa soffrire di più: non poter fare a meno di queste gioie che da, un lato ti nutrono e dall’altro ti mantengono dentro quella situazione, impedendoti di uscirne. Ma provo rabbia, perché mi rendo conto che poggia su basi infide, di cooptazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per concludere ecco la risposta dell’autrice: «GRAZIE Michela, sei riuscita a rendere lievi anche le mie durezze e fierezze così come la mia radicale anima di donna con le donne… L’hai fatto anche per riuscire a farmi ascoltare da chi non mi conosce ma può intendere… SONO FELICE che questo faccia parte della relazione che con te ho potuto e voluto avere. Riconoscersi perfino nelle diversità tra noi (e con le altre donne) che tu riesci a mettere “a” contatto e “in” contatto é il vero piacere che sanno esprimere i corpi di donna… e su cui un nuovo paradigma dei rispetti può iniziare».